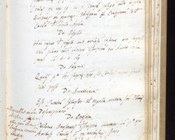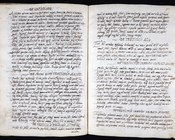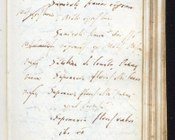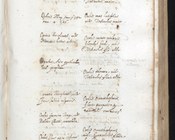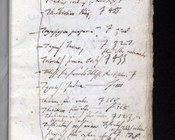“Herba palma Christi a mani e a pedi e da ogni altro membro che fosse enfiato tolli le foie de questa erba palma Christi e cocila in vino e ponilla poy in su lo membro enfiato per X die e si dess[..]ni fierae e guarisse e de cosa proata. A fregitade de corpo per tro omori fredi tolli de questa erba palma Christi e dagline a magnare de la radice per spacio de XV die rescalda el calore naturale e alegra lo core e coglila de magio a diexe di de la luna”.
BUB, Ms. Aldrovandi 153, carta 24r
Ulisse Aldrovandi riteneva che fosse necessario ampliare lo sguardo e la mente verso discipline diverse così da trarne un metodo di indagine più efficace. Tale metodo si realizzava attraverso l’osservazione diretta delle cose naturali e con lo studio, ma anche grazie allo scambio di idee e di esperienze.
Egli fu un maestro preoccupato di coinvolgere i suoi studenti non solo nelle sue ricerche ma pure nell’organizzazione pratica delle conoscenze, per creare, cioè, gli strumenti di accesso a saperi che si possono definire enciclopedici tanto spaziano nelle diverse discipline, per una più fruttuosa condivisione e consultazione. Nei manoscritti infatti si riconoscono le grafie di molti dei suoi collaboratori che compilarono indici e trascrissero citazioni e brani.
I risultati delle ricerche di Aldrovandi sono raccolti in 382 volumi manoscritti; a questi vanno aggiunti i diciotto codici con le tavole dipinte, e l’Erbario secco, conservato presso l’Orto botanico, contenente circa 5000 campioni di piante ordinati in quindici volumi.
Nei manoscritti si possono consultare relazioni dall’osservazione diretta dei fenomeni naturali (per es. in BUB, Ms. Aldrovandi 136/III) e miscellanee di estratti da testi scientifici, letterari, di carattere religioso, in cui sono stati trattati, a volte solo citati, gli argomenti ritenuti interessanti. Aldrovandi intendeva arrivare a tutte le informazioni possibili grazie alla lettura di autori antichi e contemporanei perché riteneva che queste sarebbero state la base da cui partire per nuovi ragionamenti (ecco spiegata la presenza nella sua biblioteca anche di erbari medievali come il manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi 153, in cui si ritrovano rappresentazioni simboliche e allusive alle caratteristiche delle erbe, legate a una concezione più magica che scientifica).
La sua biblioteca è ricchissima di testi antichi e a lui contemporanei, a stampa e manoscritti, tutti studiati e annotati da lui stesso e dai suoi collaboratori. Le annotazioni sono state ordinate in forma di indici, di elenchi di nomi e di citazioni in ordine alfabetico, spesso organizzate in schedine di varie dimensioni incollate sulla pagine dei volumi come nel manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi 145/II della bacheca A.
Il percorso delle sue ricerche può essere ricostruito anche grazie alle tavole sinottiche presenti del manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi 97, o leggendo i volumi con testi organizzati secondo gli argomenti nel codice BUB, Ms. Aldrovandi 98/I.
Nella maggior parte dei codici, però, all’interno dello stesso volume i soggetti trattati sono diversi, intrecciati fra loro, anche letteralmente: si alternano descrizioni di animali estratte da opere scientifiche e letterarie, osservazioni sulle piante, riflessioni su strategie militari, trascrizioni di corrispondenza. Queste miscellanee si trovano spesso sotto il titolo di Farrago: il termine farrago indicava una mescolanza di erbe diverse utilizzata per il bestiame, ma anche, in senso figurato, una moltitudine confusa di cose eterogenee, e come tali si presentavano ampie sezioni in cui Aldrovandi raccolse e fece raccogliere testi sui temi più disparati.
Importanti per valutare i risultati della sua ricerca sono i poderosi volumi dedicati alla corrispondenza, sia ricevuta sia inviata, in buona parte trascritta dai suoi collaboratori; in molti casi le lettere contengono vere e proprie disquisizioni scientifiche, inviate ad altri studiosi, italiani e stranieri, come Pietro Andrea Mattioli, Luca Ghini, Gabriele Falloppio e Joachim Camerarius il Giovane, oppure a personaggi autorevoli che avrebbero potuto aiutarlo nel prosieguo del suo lavoro, tra i quali i fratelli Paleotti, Gabriele, arcivescovo di Bologna, e Camillo, il senatore che molto lo sostenne anche nella creazione dell’Orto botanico, e i Granduchi di Toscana Francesco I e Ferdinando I de’ Medici. 
Riferimenti bibliografici delle opere che costituiscono la sezione:
- Erbario alchemico
Cartaceo, sec. XV prima metà
cc. I, 50, I’
BUB, Ms. Aldrovandi 153
Nell’erbario quattrocentesco appartenuto ad Aldrovandi si trova una Palma Christi, un’orchidea. La forma delle radici antropomorfiche permette di identificare una Dactylorhiza maculata. Pur essendo un tipico erbario alchemico, in cui venivano mescolate magia e medicina, botanica e alchimia, e dove le immagini erano di solito proposte a un livello di astrazione importante, le caratteristiche esteriori della pianta sono rispettate e l’orchidea è riconoscibile. In questa ricetta ne viene consigliato l’uso per liberarsi da edemi, una terapia che trova origine nei testi del medico greco Dioscoride (sec. I).
- ALDROVANDI, ULISSE
De satiriis
Cartaceo, 1550-1605
cc. III, 148; III’
BUB, Ms. Aldrovandi 98/I
Nei quattro volumi del manoscritto, Aldrovandi ha annotato gli esiti delle sue osservazioni e dei suoi studi. In questa pagina del vol. I, all’interno di una serie di note sulle piante (cc. 66r-78r), troviamo il riferimento a Valerio Cordo (1515- 1544), considerato uno dei padri della botanica tedesca, e del quale Aldrovandi possiede un manoscritto sulla storia delle piante (Historia plantarum)
- CORDUS, VALERIUS
Historia Plantarum
Cartaceo
sec. XVI
cc. X, 167
BUB, Ms. 561
Il medico Valerio Cordo (1515-1544) era figlio del celebre botanico Euricius Cordus. Valerio tenne numerose lezioni sull’opera di Dioscoride all’Università tedesca di Wittenberg, ma non pubblicò mai i risultati delle sue ricerche, che circolarono solo manoscritti. Nel codice esposto si leggono le descrizioni delle piante e degli habitat, risultato sia del proprio lavoro sia di quello paterno.
- ALDROVANDI, ULISSE
Catalogus earum plantarum quae sunt mihi in libris aglutinatae, sed desiderantur pro horto publico
Cartaceo
1568
cc. I, 298, I’
BUB, Ms. Aldrovandi 136/III
In uno degli elenchi contenuti nel terzo dei 32 volumi del Ms. 136 dedicato alle piante utili per l’Orto pubblico e poi conservate nell’Erbario secco, si leggono anche i luoghi in cui Aldrovandi poté osservare le orchidee: nella pagina scelta vengono enumerate le specie del Satyrion trovate nei dintorni di Bologna e di Trento e sul monte Baldo.
- ALDROVANDI, ULISSE
Microcosmi nostri, sive Theatri nostri naturae descriptio in genere
Cartaceo
1565-1592
cc. VII, 693, III’
BUB, Ms. Aldrovandi 97
Lo schema in questa pagina si sofferma anche sui Bulbosarum plantarum genera, i generi delle piante bulbose, la cui produzione di fiori avviene tramite i bulbi (geofite bulbose). Tra queste ci sono le orchidee sotto il nome di Satyrium, di Palma Christi e di Testiculum canis ma anche giacinti, narcisi e ciclamini. Le tavole sinottiche che si sviluppano, argomento per argomento, nel Microcosmi nostri sono utilizzate da Aldrovandi per riassumere e schematizzare le sue ricerche, per renderle comprensibili e percorribili anche ad altri studiosi.
- ALDROVANDI, ULISSE
Elenchus plantarum agglutinatarum
Cartaceo
1550-1605
cc. IV, 298, I’
BUB, Ms. Aldrovandi 89/I
Nel manoscritto si legge uno degli elenchi delle piante raccolte nell’erbario secco. Alla lista delle piante segue quella dei semi conservati in uno degli armadi del Museo aldrovandiano. I due volumi che compongono il manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi 89 sono legati al manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi 2 esposto nella bacheca 1. Sono stati scritti dallo stesso copista, identificabile con uno dei suoi collaboratori più assidui, Guglielmo de Triulx.
- ALDROVANDI, ULISSE
Index Plantarum pictarum a Magistro Ioanni de Neris pictor a Sancto Ioanni
Cartaceo
1558-1590
cc. 36, I’
BUB, Ms. Aldrovandi 47
Il codice, di mano di Aldrovandi, contiene l’indice alfabetico delle tavole delle piante realizzate da Giovanni Neri, pittore al servizio di Aldrovandi dal 1558 al 1590 circa. A c. 31r si legge l’indicazione del Testiculus mas minor. Testiculus serapias flore castanei colorisf 78, che si riferisce alla c. 78 del manoscritto BUB, Ms. Aldrovandi, Tavole di piante, fiori e frutti, vol. 8, esposto nella bacheca centrale.
- Modello di Giglio caprino, Orchis morio L.
Cartapesta/modellato/verniciatura, , cera/modellato/verniciatura, legno/verniciatura
Seconda metà XIX sec./ prima metà XX sec.
39x8x13 cm, 400 gr
Manifattura Brendel, Berlino
Orto Botanico ed Erbario, Sistema Museale di Ateneo, n.56 Orchis morio Linn. Gigli caprini di prato. Orchidee